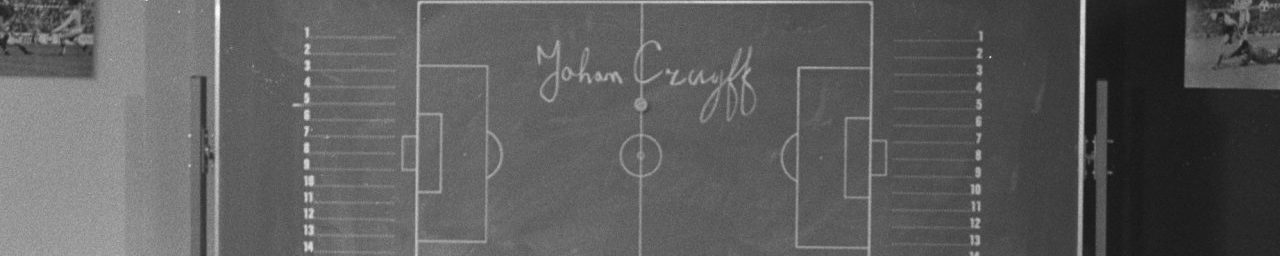Nell’intervallo della finale di FA Cup del 1948 fra Blackpool e Manchester United, con la sua squadra sotto di un gol nonostante un gioco di livello evidentemente superiore, il capitano dei Red Devils Johnny Carey teme che i compagni stiano perdendo fiducia nelle proprie idee. «Just go on playing football. The goals will come». Raccontato da Willy Meisl nel suo Soccer Revolution, questo episodio potrebbe essere letto come esemplare di una sorta di disturbo esistenziale del calcio totale. Quando fai tutto bene, eppure non basta. Quando fatichi a spiegarti perché non basta. Quando fra te e la frustrazione perde chi abbassa gli occhi per primo. Si corre continuamente questo rischio, in un calcio fatto di dedizione e sensibilità, e basta dare un’occhiata alla galassia di atti mancati che ne punteggia la storia per rendersene conto. Olanda-Germania Ovest, finale mondiale del 1974, è soltanto il caso più celebre e studiato. Si fa quello che si deve, ma poi accade quello che può. Lo sapeva Cruijff, che però era bravo a dribblare il dubbio iperbolico e andare sempre avanti. Lo sa ancora meglio Pep Guardiola, che rispetto al suo maestro ha una più spiccata tendenza all’autoesame e dunque è più soggetto agli agguati della frustrazione. Anzi, se c’è una costante nella narrazione della sua carriera di allenatore, è proprio il momento di massima distanza fra l’idea e la sua realizzazione. È successo all’inizio della sua esperienza al Barcellona, all’inizio e in parte anche nel corso di quella al Bayern Monaco, sta succedendo ora al Manchester City. Con la differenza che questa volta sta durando un po’ più a lungo. E che questa volta Pep non può andare a parlarne con Cruijff.
Come nel 2008, quando Barcellona si divideva ancora fra romanticismo per il capitano ritornato e scetticismo per la sua mancanza di esperienza, dopo un’estate di parole e pioggia, ma soprattutto di promesse, di quelle che capisci quanto siano grandi solo dopo che le hai fatte. Guardiola sapeva quello che faceva, quando aveva accettato la panchina della prima squadra, la squadra di cui era stato capitano e anima e che probabilmente se avesse un volto, sarebbe il suo. Sapeva quello che faceva durante gli allenamenti maledettamente intensi della preparazione estiva, mentre in città qualcuno si chiedeva se sarebbe riuscito a farsi ascoltare da uno spogliatoio di stelle, alcune delle quali fresche di titolo europeo con la nazionale spagnola. Sapeva quello che faceva anche quando preparava la partita d’esordio in Liga – la sua prima volta su una panchina professionistica. La trasferta sul campo del neopromosso Numancia poteva considerarsi un debutto soft: quindi per favore, aprire il campo, far circolare rapidamente il pallone e avere pazienza. Senonché il Barcellona fa l’esatto contrario e attacca per vie centrali, finendo nell’imbuto dell’affollatissima area di rigore del Numancia. In compenso tiene la palla e tira in porta, addirittura 23 tiri complessivi contro uno solo per i padroni di casa. Che però è anche l’unico della partita a finire in rete. Numancia-Barcellona 1-0. L’umore nello spogliatoio blaugrana non è esattamente il massimo. Guardiola entra, guarda le facce scure dei giocatori. Poi dice una cosa che sarebbe diventata presto una citazione: «Non dobbiamo perdere di vista la nostra idea». Passa una settimana e il Barcellona gioca la prima stagionale al Camp Nou, avversario il modesto Racing Santander. Finale, 1-1. Un risultato frustrante, non tanto per i due punti buttati, quanto per la prestazione: Guardiola ha visto la squadra giocare come dice lui, ma non è bastato. Il giorno dopo, mentre il tecnico cerca di arginare i dubbi e i giornali già si interrogano sull’adeguatezza di Pep, Andrés Iniesta, che contro il Racing era partito dalla panchina, si affaccia nell’ufficio del suo allenatore: «Non ti preoccupare, mister. Voglio che tu sappia che siamo tutti con te».
Le parole che mettono definitivamente in fuga i dubbi vengono però da Johan Cruijff, che all’indomani del pari con il Santander prende pubblicamente le parti di Guardiola, scrivendo sul quotidiano El Periódico che quello era «il miglior Barcellona che abbia visto da tanti anni a questa parte». Durante la sosta del campionato che segue l’1-1 del Camp Nou, Pep e Johan si incontrano per uno dei loro lunghi pranzi a base di calcio e Cruijff –  dal quale pure Guardiola si sente lontanissimo, almeno in termini di autorità – incoraggia il suo allievo ad andare avanti per la sua strada: «Devi essere capace di prendere decisioni rischiose con un margine di tempo ridotto. Nel corso della tua carriera hai ricevuto tante influenze, adesso è il momento di andare avanti a modo tuo». E ancora: «L’obiettivo è insegnare l’abc del calcio a ogni giocatore, e quando le cose non funzionano dovrai tornare sempre all’abc. La cosa più importante è avere delle regole: non chiedere a un giocatore di fare qualcosa che non sa fare, chiedigli che faccia quello che sa fare meglio. Tutta la squadra deve condividere la stessa idea. E non perdere di vista l’autorità». Nel salutare Guardiola al termine del pranzo, Cruijff gli lascia un messaggio chiaro: «Sigue así, Pep. Acabará por suceder». Continua così, Pep. Alla fine funzionerà.
dal quale pure Guardiola si sente lontanissimo, almeno in termini di autorità – incoraggia il suo allievo ad andare avanti per la sua strada: «Devi essere capace di prendere decisioni rischiose con un margine di tempo ridotto. Nel corso della tua carriera hai ricevuto tante influenze, adesso è il momento di andare avanti a modo tuo». E ancora: «L’obiettivo è insegnare l’abc del calcio a ogni giocatore, e quando le cose non funzionano dovrai tornare sempre all’abc. La cosa più importante è avere delle regole: non chiedere a un giocatore di fare qualcosa che non sa fare, chiedigli che faccia quello che sa fare meglio. Tutta la squadra deve condividere la stessa idea. E non perdere di vista l’autorità». Nel salutare Guardiola al termine del pranzo, Cruijff gli lascia un messaggio chiaro: «Sigue así, Pep. Acabará por suceder». Continua così, Pep. Alla fine funzionerà.
Cinque anni più tardi, ancora agosto, ancora nuvole di dubbi che si addensano sul cielo sopra Guardiola, che da due mesi scarsi allena il Bayern Monaco campione d’Europa. Due mesi di lavoro ininterrotto per insegnare alla squadra concetti e movimenti che conosce solo in parte, tutta la fatica fatta per spiegare ai giocatori che delle corse in cima alla collina si può anche fare a meno, davvero. Estenuanti ripetizioni dei movimenti in uscita dalla propria trequarti: «Portate fuori il pallone bene e giocherete bene». La Supercoppa Europea contro il Borussia Dortmund deve essere il primo vero esame per verificare se l’idea è stata afferrata. Ma al Westfalenstadion il Bayern si vede impartire una lezione di Umschaltungsspiel, la transizione fulminante fra difesa e attacco di cui Jürgen Klopp è maestro. Finisce 3-1 e per Pep è il secondo trofeo perso in carriera dopo la Coppa del Re 2011 contro il Real Madrid. Forse non è stato capace di leggere la partita abbastanza rapidamente? Forse ha chiesto ai suoi giocatori cose che non sanno fare? I dubbi di Guardiola si possono quasi toccare nella conferenza stampa post gara, in cui il tecnico è visibilmente altrove con il pensiero. Come cinque anni prima a Numancia, c’è Manel Estiarte seduto accanto a Pep sul pullman che riporta a casa la squadra. La sensazione di aver già vissuto un momento così è chiara a entrambi. Non si dicono una parola. Però si scambiano un’occhiata. Avanti così, alla fine funzionerà.
Sono passati altri quattro anni e il Numancia d’Inghilterra è forse la trasferta in casa del Monaco, da cui il Manchester City di Guardiola esce con addosso sensazioni contrastanti e anche difficili da interpretare: un tempo regalato al Monaco, un tempo passato a dominare il Monaco. Bastano 45 minuti su 180 per essere sbattuti fuori dalla Champions League agli ottavi, e a Pep non era mai successo di uscire così presto. «Puoi anche giocare male, davvero. Ma tre o quattro minuti, non un tempo intero». Già dopo la partita d’andata – un avventuroso 5-3 per il City – Arrigo Sacchi aveva diagnosticato alla squadra di Guardiola un problema di pressing. Problema apparso in tutta la sua drammaticità nel primo tempo di Montecarlo, con il City praticamente fermo. Il club dei delusi da Guardiola ha già raccolto parecchi iscritti. Ma chi conosce la sua storia da allenatore, può forse provare a inserire questo episodio nell’ambito del quadro generale della prima stagione di Pep in Inghilterra: il City aveva cominciato il campionato asfaltando la concorrenza. Finché è riuscito a pressare e recuperare palla in pochi secondi, non ce n’è stato per nessuno, nemmeno per il Chelsea di Conte, che pure ha vinto la partita nel girone d’andata facendo più o meno la figura del Numancia. Poi qualcosa si è rotto – il ginocchio di Ilkay Gündogan, per l’esattezza. A quel punto Pep avrebbe potuto dare retta alla storia del calcio inglese e mettere in mezzo al campo i muscoli più potenti della  squadra, quelli di Yaya Touré. Sarebbe stato facile, perfino logico. Invece è andato avanti per la sua strada. Ancora, e anche se stavolta non c’era Cruijff a ricordarglielo. In mezzo al campo ha messo i due giocatori di maggior talento che ha, lo spagnolo David Silva e il belga Kevin De Bruyne, di fatto due ex ali. Ha preferito tornare ai fondamentali e insegnare loro l’abc della regia piuttosto che piegare le sue idee alla tradizione di un campionato storicamente refrattario a un certo tipo di calcio. All’inizio fu uno studio, diceva Rimbaud. Quando tagliano in profondità con passaggi millimetrici, è un altro mondo che si apre. Ma quando devono rincorrere un avversario più potente fisicamente, fanno fatica. Ed è anche maledettamente frustrante.
squadra, quelli di Yaya Touré. Sarebbe stato facile, perfino logico. Invece è andato avanti per la sua strada. Ancora, e anche se stavolta non c’era Cruijff a ricordarglielo. In mezzo al campo ha messo i due giocatori di maggior talento che ha, lo spagnolo David Silva e il belga Kevin De Bruyne, di fatto due ex ali. Ha preferito tornare ai fondamentali e insegnare loro l’abc della regia piuttosto che piegare le sue idee alla tradizione di un campionato storicamente refrattario a un certo tipo di calcio. All’inizio fu uno studio, diceva Rimbaud. Quando tagliano in profondità con passaggi millimetrici, è un altro mondo che si apre. Ma quando devono rincorrere un avversario più potente fisicamente, fanno fatica. Ed è anche maledettamente frustrante.
Continua così, Pep. Alla fine funzionerà.