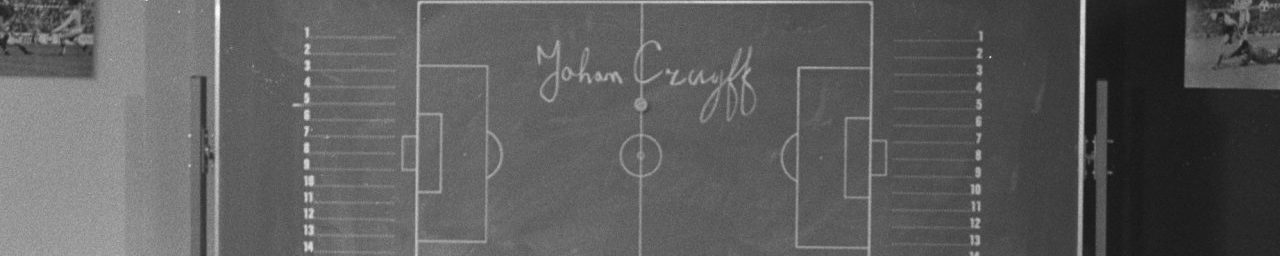Un qualunque impiegato di un calzaturificio romagnolo avrebbe usato le sue due settimane di ferie dell’estate 1983 per smaltire in Riviera le scorie di un anno di lavoro. Ma Arrigo Sacchi non era uno qualunque, e non solo perché il titolare di detto calzaturificio altri non era che suo padre. Così, invece di arrostire in spiaggia con “Amore disperato” in sottofondo, l’allora trentasettenne Sacchi aveva imboccato l’autostrada in direzione Brennero e non si era fermato prima di arrivare all’altro capo d’Europa. Amburgo, Germania Ovest, una media di 33 giorni di pioggia nei mesi estivi. Uno qualunque non l’avrebbe mai scelta come meta per una vacanza. Sacchi, che al lavoro in azienda affiancava quello di tecnico del Rimini in C1, che condivideva con i tedeschi la passione per la guida, non aveva esitato a sfidare la distanza pur di raggiungere quello che al momento per lui era il posto più interessante del mondo.
Il fatto è che Amburgo era davvero la capitale calcistica d’Europa, in quella strana estate 1983. Solo un paio di mesi prima, l’Italia si era fermata per guardare la sfida che opponeva in finale di Coppa dei Campioni l’Amburgo alla Juventus. Sulla carta, una partita senza storia – la Juve metteva in campo metà della Nazionale che appena un anno prima aveva trionfato al Mondiale spagnolo più Michel Platini, che da solo guadagnava quanto metà della rosa dei tedeschi. Sul campo, invece, di storia ce n’era stata eccome: il gol di Felix Magath in apertura aveva messo la gara sui binari ideali per l’Amburgo, i cui giocatori si erano battuti come leoni per difendere il vantaggio fino alla fine e riportare in Germania la Coppa Campioni a sette anni dall’ultimo dei tre successi consecutivi del Bayern Monaco. Ad Arrigo Sacchi la notte di Atene aveva aperto gli occhi. Se già si era convinto che da grande avrebbe fatto l’allenatore professionista, la finale di Coppa Campioni gli aveva mostrato che tipo di allenatore voleva diventare – ironia delle sorte, in una partita che vista in retrospettiva non potrebbe essere meno sacchiana.
Paradossalmente, l’allora aspirante allenatore condivideva con il tecnico dell’Amburgo la convinzione che fosse meglio perdere 4-5 che giocare da 0-0. Il che nell’estate 1983 era un’idea poco diffusa in Italia e ai limiti del rivoluzionario in Germania. Ad Amburgo, però, il piacere per il calcio offensivo era qualcosa di più che una suggestione. Tutto era  cominciato nel 1977, quando Günter Netzer, subito dopo il suo ritiro, si era candidato per un ruolo organizzativo all’Amburgo: si immaginava responsabile del giornale distribuito allo stadio, invece gli avevano offerto di fare il direttore sportivo. Primo compito, scegliere il nuovo allenatore. Netzer, che si era formato alla scuola del Borussia Mönchengladbach di Hannes Weisweiler ed era stato grande protagonista nella nazionale di Helmut Schön campione d’Europa nel 1972, non poteva che rivolgersi a un tecnico che amasse attaccare e liberasse la squadra dai vincoli dell’allora imperante marcatura a uomo. E chi meglio di Ernst Happel, viennese di scuola Rapid, nazionale austriaco ai Mondiali svizzeri del 1954 e soprattutto artefice del grande Feyenoord campione d’Europa nel 1970? A Rotterdam, con una squadra di talento diretta dall’elegante regia di Franz Hasil e Wim van Hanegem, aveva introdotto un tipo di pressing molto aggressivo per l’epoca, grazie al quale anche giocatori meno dinamici come lo stesso Van Hanegem («era lento e superato già nel 1973», avrebbe detto di lui Rinus Michels) si esaltavano proprio perché, grazie alla pressione organizzata sugli avversari, non avevano bisogno di correre come maratoneti. Happel faceva giocare il suo Feyenoord con il 4-4-2, modulo insolito alla fine degli anni Sessanta, e senza marcatura a uomo: ai suoi giocatori, tanto in attacco quanto in difesa, chiedeva piuttosto di coprire gli spazi, come nella migliore tradizione austro-ungherese.
cominciato nel 1977, quando Günter Netzer, subito dopo il suo ritiro, si era candidato per un ruolo organizzativo all’Amburgo: si immaginava responsabile del giornale distribuito allo stadio, invece gli avevano offerto di fare il direttore sportivo. Primo compito, scegliere il nuovo allenatore. Netzer, che si era formato alla scuola del Borussia Mönchengladbach di Hannes Weisweiler ed era stato grande protagonista nella nazionale di Helmut Schön campione d’Europa nel 1972, non poteva che rivolgersi a un tecnico che amasse attaccare e liberasse la squadra dai vincoli dell’allora imperante marcatura a uomo. E chi meglio di Ernst Happel, viennese di scuola Rapid, nazionale austriaco ai Mondiali svizzeri del 1954 e soprattutto artefice del grande Feyenoord campione d’Europa nel 1970? A Rotterdam, con una squadra di talento diretta dall’elegante regia di Franz Hasil e Wim van Hanegem, aveva introdotto un tipo di pressing molto aggressivo per l’epoca, grazie al quale anche giocatori meno dinamici come lo stesso Van Hanegem («era lento e superato già nel 1973», avrebbe detto di lui Rinus Michels) si esaltavano proprio perché, grazie alla pressione organizzata sugli avversari, non avevano bisogno di correre come maratoneti. Happel faceva giocare il suo Feyenoord con il 4-4-2, modulo insolito alla fine degli anni Sessanta, e senza marcatura a uomo: ai suoi giocatori, tanto in attacco quanto in difesa, chiedeva piuttosto di coprire gli spazi, come nella migliore tradizione austro-ungherese.
Ora, se portare tutto questo in Olanda era stato relativamente semplice – le influenze delle correnti difensiviste svizzere e italiane erano minime –, tutt’altra impresa richiedeva il trapianto nella vicina Germania. All’inizio degli anni Ottanta, la Bundesliga era la riserva europea del libero alle spalle della difesa, nonostante nessuno dei giocatori in attività interpretasse il ruolo così come era stato ridefinito un decennio prima da Franz Beckenbauer. Invece di registi arretrati con libertà di avanzare, in giro si vedevano solo guardiani dell’area piccola, schierati alle spalle di ben tre marcatori a uomo. L’ostilità a ogni forma di deviazione da questo paradigma era prima di tutto quella della Federazione, che nel 1977 aveva bloccato l’ingaggio di Happel, ufficialmente per motivi burocratici, ma in realtà temendo il contagio di malattie esotiche. Solo nel 1981 il tecnico viennese era riuscito a ottenere una deroga, forse perché insieme a lui sbarcava in Bundesliga il suo antico rivale Rinus Michels, atteso dalla panchina del Colonia. Una volta  arrivato ad Amburgo – con grande soddisfazione di Netzer – era andato dritto al punto con i suoi giocatori: quando si perde la palla, invece di correre a barricarsi in difesa, si cerca di riconquistarla pressando gli avversari già nella loro metà campo. Questa era la grande intuizione di Happel, estendere il pressing a tutto il campo, dare fastidio all’avversario già a ridosso della sua area di rigore. Il che era possibile solo a patto di un altissimo grado di organizzazione, che però presupponeva a sua volta la rinuncia alla marcatura a uomo in favore di quella a zona: «Con la marcatura a uomo hai in campo undici somari», soleva dire Happel. Solo con la zona si poteva ottenere la superiorità numerica nelle vicinanze della palla, che poi è lo scopo del pressing organizzato: isolare il giocatore in possesso palla tagliandogli tutte le linee di passaggio.
arrivato ad Amburgo – con grande soddisfazione di Netzer – era andato dritto al punto con i suoi giocatori: quando si perde la palla, invece di correre a barricarsi in difesa, si cerca di riconquistarla pressando gli avversari già nella loro metà campo. Questa era la grande intuizione di Happel, estendere il pressing a tutto il campo, dare fastidio all’avversario già a ridosso della sua area di rigore. Il che era possibile solo a patto di un altissimo grado di organizzazione, che però presupponeva a sua volta la rinuncia alla marcatura a uomo in favore di quella a zona: «Con la marcatura a uomo hai in campo undici somari», soleva dire Happel. Solo con la zona si poteva ottenere la superiorità numerica nelle vicinanze della palla, che poi è lo scopo del pressing organizzato: isolare il giocatore in possesso palla tagliandogli tutte le linee di passaggio.
In realtà, spiega Tobia Escher nel suo “Vom Libero zur Doppelsechs”, quella dell’Amburgo era una rivoluzione a metà: se in casa stupivano con il loro calcio aggressivo, in trasferta avevano un atteggiamento più prudente. Eppure degli elementi di novità c’erano, a cominciare dal ruolo dei terzini – soprattutto il destro, Manni Kalz – che non erano solo autorizzati, ma obbligati ad avanzare: il cross di Kalz per la testa di Horst Hrubesch era una delle giocate preferite dell’Amburgo, laddove il passaggio dall’esterno per il centravanti era stato fino a quel momento in Germania compito esclusivo delle ali. Nella finale di Coppa contro la Juve, in realtà, di tutti questi movimenti se n’erano visti ben pochi. Pensando a come venire a capo della corazzata allenata da Giovanni Trapattoni, Happel si era convinto della necessità di derogare almeno in parte ai suoi principi e mettere un marcatore a uomo su Platini. Siccome, però, i suoi giocatori erano sinceramente convinti dell’efficacia del loro stile di gioco, bisognava che si convincessero da soli che quella era la soluzione migliore. Così, alla vigilia della sfida, Happel li aveva portati a fare una lunga passeggiata su un campo da golf e li aveva stimolati a discutere degli aspetti tattici della partita. Al rientro in hotel, la squadra era convinta che dichiarare lo stato d’eccezione e mandare Wolfgang Rolff a uomo su Platini fosse una sua idea. L’espediente si rivela vincente non tanto per le doti di mastino di Rolff, quanto perché al suo vincolo di marcatura fa da contraltare la completa libertà che Happel concede al playmaker Felix Magath, che dirige i giochi da centro del campo, supportato dal terzino Kalz. Questi lascia da parte le avanzate sulla fascia – dove d’altra parte sarebbe stato facile preda di Cabrini – per accentrarsi e andare a fare il regista aggiunto, creando superiorità numerica in una zona del campo completamente imprevista per la Juventus. Nell’azione del gol decisivo, Magath riesce a liberarsi del suo marcatore proprio perché ha a disposizione lo spazio lasciato libero da Kalz.
È vedendo tutto questo che Arrigo Sacchi ha una specie di folgorazione. Decide che vuole saperne di più, vuole osservare da vicino il lavoro di Happel. Le due settimane amburghesi dell’estate 1983 valgono bene i chilometri. Sacchi si aspetta di assistere a  dettagliate lezioni di tattica, invece il tecnico viennese non usa nemmeno la lavagna. Tutte le sue idee le porta direttamente in allenamento, dove più che spiegarle, le fa vedere. I giocatori quasi non si accorgono che stanno ricevendo un insegnamento tattico e tuttavia mettono subito in pratica il sistema di Happel. Un esercizio in particolare colpisce Sacchi: su un campo di dimensioni ridotte, si gioca una partita in cui solo i difensori sono autorizzati a segnare e solo gli attaccanti a cercare di recuperare la palla. In questo modo Happel allena la fase difensiva dei suoi attaccanti e quella offensiva dei suoi difensori. Sacchi chiude tutto in valigia e quando riparte per Fusignano ha chiara la sensazione di aver imparato qualcosa che presto gli tornerà utile. Su tutte, l’idea di estendere il pressing all’intero campo grazie a movimenti organizzati. Tradotto nel suo linguaggio diventerà «bisogna che tutti si aiutino». Non male per un souvenir.
dettagliate lezioni di tattica, invece il tecnico viennese non usa nemmeno la lavagna. Tutte le sue idee le porta direttamente in allenamento, dove più che spiegarle, le fa vedere. I giocatori quasi non si accorgono che stanno ricevendo un insegnamento tattico e tuttavia mettono subito in pratica il sistema di Happel. Un esercizio in particolare colpisce Sacchi: su un campo di dimensioni ridotte, si gioca una partita in cui solo i difensori sono autorizzati a segnare e solo gli attaccanti a cercare di recuperare la palla. In questo modo Happel allena la fase difensiva dei suoi attaccanti e quella offensiva dei suoi difensori. Sacchi chiude tutto in valigia e quando riparte per Fusignano ha chiara la sensazione di aver imparato qualcosa che presto gli tornerà utile. Su tutte, l’idea di estendere il pressing all’intero campo grazie a movimenti organizzati. Tradotto nel suo linguaggio diventerà «bisogna che tutti si aiutino». Non male per un souvenir.