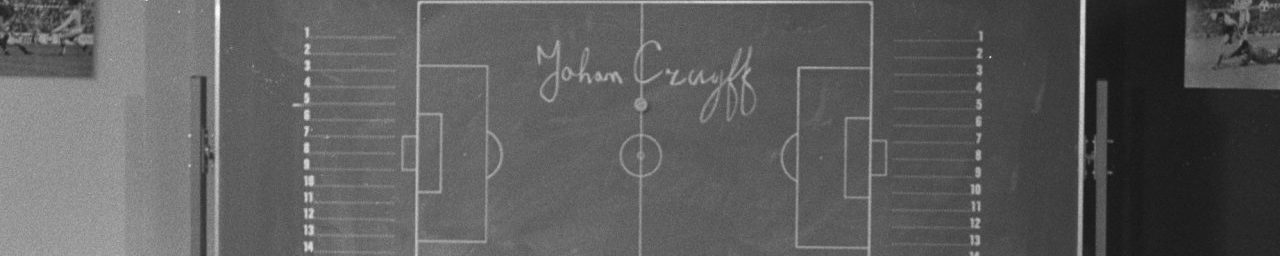Talmente bello da non riuscire a trattenere le lacrime guardandolo. Non è un modo dire: «Stava solo calciando un pallone, ma a me veniva da piangere». Così si sentiva Jan Mulder quando si allenava con Rob Rensenbrink nella stagione 1970/71. Mentre tutto il mondo si innamorava dell’Ajax di Cruijff, all’Anderlecht si sospirava per un altro ragazzo. Un ragazzo nato ad Amsterdam nel 1947, proprio come Johan, ma cresciuto abbastanza lontano dal De Meer da restare fuori dal giro dell’Ajax. Rob non ha difetti congeniti alle caviglie, eppure nessuno dribbla come lui – nemmeno Johan, forse. Rob è alto, magro e ha quei grandi occhi blu che solo gli olandesi. Rob somiglia così tanto a Johan da far venire le vertigini perfino alla redazione del Guardian, che ha messo la sua foto a corredo di un pezzo dedicato alla morte di Cruijff. Ma Rob è diverso. Rensenbrink è il cavaliere azzurro nell’universo arancione del calcio totale. È Amsterdam che si trasferisce a Bruxelles – tulipani nella nebbia e l’aria che sa di zucchero. È la bellezza quando sconfina nella disperazione.
Se n’era andato da Amsterdam a ventidue anni, dopo averne passati dieci nel DWS, uno dei tanti club cittadini. Nel vicino Belgio, la prima tappa è Bruges, forse perché i canali un po’ gli ricordano casa. Due stagioni di magie convincono l’Anderlecht a prenderlo per fare il salto di qualità. Funziona: nelle nove stagioni in cui resta a Bruxelles, oltre ai titoli nazionali, arrivano due Coppe delle Coppe, nel 1976 e nel ‘78. Di lui impressiona innanzitutto il modo in cui si muove, con una sinuosità che gli vale subito il soprannome “De Slangemens”, l’uomo serpente. Mancino, veloce, elegantissimo. «Qualcuno dice che era un artista, ma secondo me è qualcos’altro – continua Mulder – Alcuni la chiamano “la bellezza del gesto”. Era come la scrittura a mano. Robbie aveva una bellissima calligrafia».
Eppure, quando il ct Rinus Michels lo inserisce nella lista dei convocati per il Mondiale tedesco del 1974, in Olanda non lo conosce quasi nessuno. La tv belga arriva poco oltre confine e lui in nazionale fino a quel momento s’è visto pochissimo. L’Anderlecht non gioca il calcio dell’Ajax, perché l’allenatore Raymond Goethals – che una ventina d’anni dopo porterà il Marsiglia sul tetto d’Europa – preferisce il 4-4-2, che per Rensenbrink è una specie di tana libera tutti, visto che la maggior parte delle volte può pensare soltanto a saltare il suo diretto avversario. E poi un altro. E un altro. E un altro ancora. Sempre Mulder: «Una volta contro il Bayern Monaco in Supercoppa l’ho visto dribblare per tutto il tempo Beckenbauer, Breitner e Schwarzenbeck». Nell’Olanda di Michels, però, il dribbling è un tesoro riservato a pochi. A Cruijff, più che altro, che gioca proprio nel ruolo che a Rensenrink sarebbe più congeniale, largo a sinistra. Basterebbe poco per trasformare il dualismo nel leitmotiv dell’intero torneo, in realtà la rivalità rimane inespressa. «Non ho mai discusso con Cruijff – ha raccontato Rensenbrink – Per me non era un problema. Giocavamo bene e vincevamo le partite. Ma io non ho mai davvero giocato sui livelli di come facevo in Belgio».
 D’altra parte, nessuno nel ritiro della nazionale si sarebbe azzardato a dire ad alta voce che forse lui era forte quanto Cruijff, e non solo perché Johan non l’avrebbe presa bene. Tanto impressionante era la somiglianza fisica, quanto profonda la differenza del carattere: Rensenbrink poteva essere taciturno ai limiti del mutismo e schivo ai limiti dello scostante. In campo, però, nessuna parola poteva tenere dietro ai suoi dribbling, nessuna frase raccontava fino in fondo quel suo toccare la palla con l’esterno del piede – una rarità per l’epoca – e poi saltare l’avversario con un giro di 360 gradi. Fa anche gol, Rensenbrink, e pure decisivi, come le doppiette che mettono nella bacheca dell’Anderlecht i primi 3 trofei europei della sua storia. Non può essere un caso che le uniche partite che l’Olanda non vince ai Mondiali siano quelle segnate dalla sua assenza: lo 0-0 con la Svezia – uno spettacolo, comunque – e la finale con la Germania, che Rob comincia senza aver smaltito l’infortunio rimediato contro il Brasile e che deve abbandonare nell’intervallo.
D’altra parte, nessuno nel ritiro della nazionale si sarebbe azzardato a dire ad alta voce che forse lui era forte quanto Cruijff, e non solo perché Johan non l’avrebbe presa bene. Tanto impressionante era la somiglianza fisica, quanto profonda la differenza del carattere: Rensenbrink poteva essere taciturno ai limiti del mutismo e schivo ai limiti dello scostante. In campo, però, nessuna parola poteva tenere dietro ai suoi dribbling, nessuna frase raccontava fino in fondo quel suo toccare la palla con l’esterno del piede – una rarità per l’epoca – e poi saltare l’avversario con un giro di 360 gradi. Fa anche gol, Rensenbrink, e pure decisivi, come le doppiette che mettono nella bacheca dell’Anderlecht i primi 3 trofei europei della sua storia. Non può essere un caso che le uniche partite che l’Olanda non vince ai Mondiali siano quelle segnate dalla sua assenza: lo 0-0 con la Svezia – uno spettacolo, comunque – e la finale con la Germania, che Rob comincia senza aver smaltito l’infortunio rimediato contro il Brasile e che deve abbandonare nell’intervallo.
Quattro anni dopo in Argentina, il suo momento sembra finalmente arrivato. Cruijff ha lasciato la nazionale, Michels pure e adesso in panchina c’è Ernst Happel, che nel 1970 aveva guidato il Feyenoord alla conquista della prima Coppa Campioni del calcio olandese. Il tecnico viennese si fida della fantasia di Rensenbrink, che lo ripaga segnando i 5 gol che trascinano l’Olanda alla sua seconda finale mondiale consecutiva, ancora contro i padroni di casa.
Il 25 giugno 1978 al Monumental di Buenos Aires l’Argentina gioca la finale che non può perdere, l’Olanda quella che non vuole vincere. Nessuno pensava che si potesse arrivare in fondo senza Cruijff, senza Michels, senza Van Hanegem. Nessuno pensa che si possa vincere un Mondiale senza che la rivincita sulla Germania sia stata consumata. Nessuno tranne Rensenbrink: il gol di Nanninga rimette la partita in parità dopo l’iniziale vantaggio di Kempes e i supplementari sono a un passo, quando capitan Krol pesca Rob a due passi dalla linea di porta, solo molto spostato a sinistra, tutto solo di fronte a Fillol in uscita. Non Cruijff, Rensenbrink. Rob il serpente allunga una gamba, la sua calligrafia disegna una lunga curva blu e spinge la palla oltre il portiere, verso la porta vuota. La palla si incammina verso la linea, verso la Coppa, verso la storia scritta da qualcuno che non sia Cruijff. Piega leggermente a sinistra. Va a sbattere sul palo. Rob la guarda rimbalzare sdraiato a terra. Ai supplementari, l’Argentina vincerà 3-1. Altri avrebbero perso il sonno, «io penso di aver fatto bene a prendere il palo. Davvero. Non avevo spazio per fare niente. Qualcuno pensa che sarebbe stato meglio se avessi mancato il pallone del tutto e che dovrei starci ancora male, ma davvero era impossibile segnare».
Rensenbrink giocherà altri due anni nell’Anderlecht e poi ancora un po’ in giro per il mondo, prima di ritirarsi dal calcio e da una certa vita. Si trasferisce fuori Amsterdam. Pesca. Cura il giardino. Per vent’anni non guarda una partita. Quando torna a parlare di calcio, nel 2000, dice quello che nessuno si aspetta: «Forse il calcio totale ha rovinato tutto. La preparazione di Michels era massacrante e introducendo tutta questa velocità esasperata, ha fatto male al calcio». Per la calligrafia c’è bisogno di quiete. Di blu. Di un altro numero sulla maglia. A proposito, il quindici.